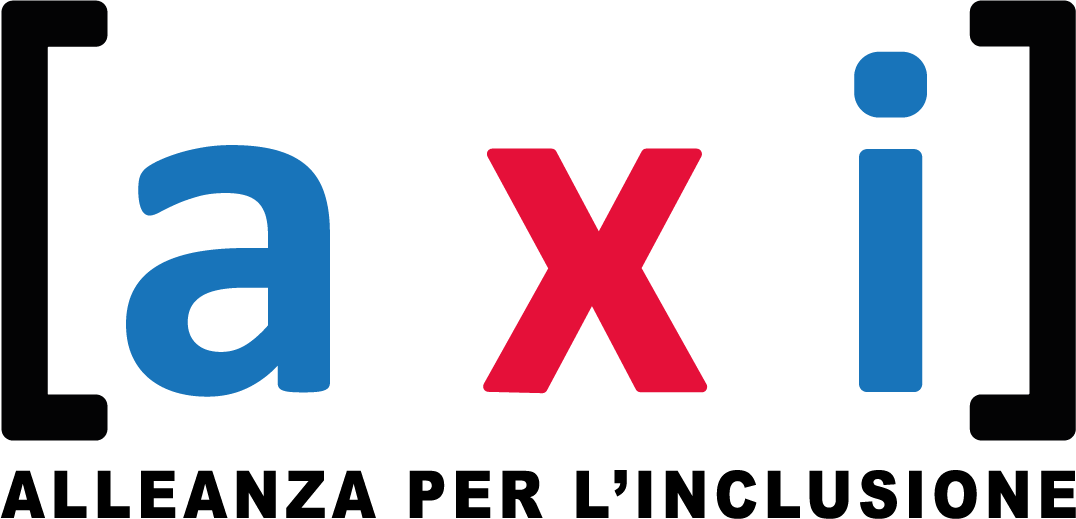È risaputo: più passano gli anni e più tutti gli accadimenti di un tempo si ammantano di un’aurea magica che porta a nobilitare situazioni una volta ordinarie, a sublimare episodi normali, a idealizzare figure a cui non si sarebbe mai pensato di dare più di tanta importanza. Potenza della psiche umana che digerisce a fatica i cambiamenti e che, man mano che l’età avanza, cede sempre più a certa nostalgia e tende a stravolgere i ricordi e, nel migliore dei casi, a rivalutare quelli più tendenti al positivo.
Ma i ricordi d’infanzia no, quelli sono generalmente esenti dalla revisione agiografica. Parlo per me, ma credo d’incontrare un buon consenso. Da che ho memoria, fino a una certa età – diciamo gli anni delle Scuole Medie – ciò che ha popolato il mio mondo nel piccolo borgo collinare in cui sono nato – duemila anime, più della metà delle quali disperse nel contado – mi appare ancor oggi nella sua nitidezza, senza lenti colorate a trasformare retroattivamente una realtà diversa da quella che ho poi vissuto in centri sempre più grandi e infine nella grande metropoli.
Le cose, tutte, avevano forme e sostanze ben chiare. Il freddo era freddo, contrastato da indumenti a strati ben lontani dal tepore dei “piumini” odierni, e il caldo era caldo, da affrontare a torso nudo, quando ancora farlo non era considerato sconveniente e le mamme non erano così protettive. La fatica era fatica e anche il gioco più appassionante diventava impegnativo su e giù per le salite e le scalinate del paese. E le differenze, certe differenze, non facevano differenza.
Nelle gare di corsa, e ancor più nelle staffette, ma anche nel calcio, nella “palla prigioniera” o nella “bandiera”, il genere misto era la normalità: maschi e femmine insieme per avere una partecipazione numericamente congrua e possibilmente, soprattutto nei giochi di squadra, rispettosa di una buona uniformità nelle potenzialità dei gruppi. Lo stesso avveniva per i due o tre coetanei con qualche disabilità (al tempo il termine era praticamente sconosciuto) che erano tutt’altro che esclusi.
Mio cugino Emidio, per tutti Mimì, per esempio, era down, ma era perfettamente accettato perché la cosa non era di nessuna importanza. Certo, nella corsa non era un fulmine, ma guai a tenerlo fuori. Paolo invece aveva un’evidente lussazione congenita all’anca che lo escludeva da alcuni giochi e lo penalizzava in altri, ma a calcio era un terzino insuperabile e per questo era richiestissimo.
È solo da adolescente e poi da adulto, che ho assodato – con una certa meraviglia nel rendermi conto del mio esagerato e ingenuo candore – che altrove chi aveva una disabilità non aveva la fortuna di essere accettato senza riserve come, seppur nel loro piccolo mondo, i miei amici d’infanzia Mimì e Paolo.
Nella mia ultradecennale attività da atleta professionista l’ho percepito lentamente, molto lentamente, perché se nella vita di tutti i giorni alcuni di quelli che partivano con uno svantaggio trovavano in qualche modo, magari a fatica, la possibilità di rientrare nel gruppo, nello sport la gara ad handicap non era proprio contemplata. Nei regolamenti in particolare, ma soprattutto nella mentalità di tanti che troppo a lungo hanno ritenuto l’ambito sportivo votato solo alla perfezione. Dallo sport “quello vero” Mimì e Paolo non erano proprio contemplati.
Noi che “eravamo davanti” abbiamo finalmente dato qualche occhiata indietro soltanto quando nell’universo antiproiettile in cui vivevamo hanno cominciato a fare breccia le istanze paralimpiche di dirigenti illuminati, per esempio l’ex pentatleta Luca Pancalli approdato alle più alte cariche del Coni, e anche di tanti che si sono rifiutati di avallare una cultura che li voleva esclusi dallo sport e hanno finalmente rivendicato pari dignità.
L’uscita “allo scoperto” di atleti dotati di grande forza interiore e particolare carisma ha fatto il resto. Se penso all’aretino Settimio Agostinelli che – pressoché unico in Italia e non sempre accettato di buon grado dagli organizzatori – negli anni Ottanta calcava le corse su strada e si spellava le mani spingendo la sedia a rotelle che utilizzava quotidianamente in famiglia e al lavoro, e confronto la sua esperienza con quella di Alex Zanardi, mi sembra di parlare della scoperta dell’America mentre si sta per volare su Marte.
Se Settimio è stato un precursore, uno di quelli che hanno aperto una strada anche se ai tempi qualcuno lo poneva a metà fra la macchietta e il fenomeno da baraccone, Alex ha costruito un’autostrada, portando la “carrozzina” – oggi handbike – a livelli tecnologici inimmaginabili quarant’anni fa e trascinando con sé un mondo di seguaci. Come Zanardi, altri hanno contribuito allo sdoganamento – mi si perdoni il termine becero – dell’attività paralimpica. Penso a Giusy Versace e Bebe Vio, per restare in Italia, senza voler dimenticare, nel bene e nel male, quell’Oscar Pistorius che per primo ha voluto sfidare sul campo i normodotati.
Beh, insomma, i “diversamente abili” – cito la denominazione ormai ufficializzata – sono ormai serenamente “allo scoperto” e, come già detto, hanno la possibilità di affinare i materiali di cui si servono per le loro performance grazie a tecnologie sempre più evolute. Tecnologie oggi condivise, e paradossalmente utilizzate per il miglioramento delle prestazioni, anche dagli atleti “normalmente abili”, in una realtà in cui il concetto di inclusione sembra diventare sempre più sentito e ricercato. Nella definizione che ne fa il sociologo tedesco Jürgen Habermas, inclusione «è quando i limiti della comunità sono aperti a tutti». Facile da capire, ma non sempre, al di là di tutto quanto si è detto finora, universalmente compreso.
«Spesso, infatti, si ritiene di aver svolto delle azioni inclusive solamente per aver dato la possibilità, a persone con disabilità per esempio, di partecipare ad attività sportive adattate. Ma la realtà ci mostra che queste opportunità, se non supportate da un’attenta analisi della persona e dalla conoscenza dei suoi bisogni, rischiano di non creare i presupposti adatti ad una vera inclusione e a far sentire la persona non del tutto accolta all’interno della comunità. Quindi analizzare vorrà dire: conoscere, scoprire, valutare, ideare, costruire ed alla fine applicare, con l’intento di aiutare ogni persona con dei “bisogni speciali” ad entrare pienamente nella società e di permetterle di goderne i pieni diritti».
Per chiarire al meglio il pensiero ho appena preso in prestito la considerazione dall’assunto istitutivo della neonata associazione Alleanza per l’inclusione che, partendo dal concetto di squadra, vuole “allearsi” metaforicamente con tutti gli artefici della vera inclusione della persona con disabilità.
Una squadra che si occuperà di svolgere attività di inclusione sociale nel mondo della disabilità, tramite attività di formazione, attività ricreative e culturali, di ricerca e di sviluppo di prodotti e di protocolli che rendano inclusiva le attività quotidiane delle persone disabili, di realizzare valutazione funzionali con la finalità di fornire “conoscenza” della persona e quindi di poter ideare e applicare soluzioni specifiche per ognuno.
Una squadra della quale mi pregio di far parte e nella quale mi auguro di riuscire a riacquisire sempre più la sensibilità dei miei anni della fanciullezza e a portare fattivamente l’esperienza vissuta in tanti anni di sport praticato e raccontato, dedicando alla memoria del caro cugino Mimì quanto di buono potrò contribuire a fare in una realtà così delicatamente complessa.
Marco Marchei